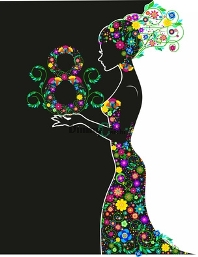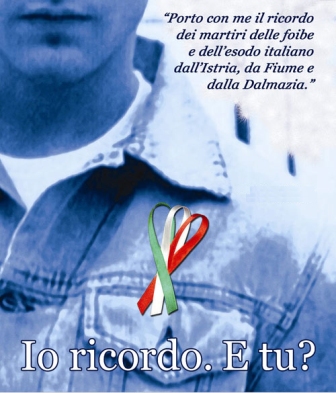In un precedente scritto (La formazione della base di calcolo del t.f.r.. spunti per una rilettura dell’art. 2120 c.c. e per una revisione critica della giurisprudenza: dall’occasionalità cronologica all’occasionalità ontologica) ho avuto occasione di rilevare come la dottrina dei prima anni ’80 avesse, molto correttamente, individuato la portata della riforma dell’art. 2120 c.c.; avevo, inoltre, evidenziato come, ciononostante, la quotidiana prassi forense avesse, di fatto, accantonato i risultati interpretativi della dottrina, per proseguire sulla falsariga della regolamentazione ante riforma, non abbandonando il principio per cui le voci retributive, da utilizzare per formare la base di computo del t.f.r., fossero quelle contraddistinte dalla loro continuità.
Per evitare inutili ripetizioni e dando per scontato il contenuto dell’articolo ricordato, mi limito in questa sede a riproporre l’approdo interpretativo, in forza del quale, la pretesa che le voci retributive, da impiegare per il calcolo del t.f.r., debbano possedere il carattere della continuità, contrasti con il nuovo testo dell’art. 2120 c.c. nonché con la ratio della norma in esame. Secondo il legislatore della riforma, infatti, il t.f.r. deve essere computato, escludendo solo i rimborsi spese nonché le somme erogate a titolo occasionale, non essendo previsto in alcuna parte che l’emolumento debba avere carattere di continuatività. Come, infatti, la dottrina ha avuto modo di precisare, l’occasionalità non deve intendersi in senso cronologico, bensì in senso causale od ontologico, giacché, la stessa non attiene alla cadenza dell’erogazione ma al titolo, con la conseguenza che tutto quanto percepito dal lavoratore nel corso del rapporto costituisce valida base per il calcolo della retribuzione differita.
L’ordinarietà delle situazioni sottoposte a esame giudiziale è rappresentata da casi in cui si discute circa l’inclusione, nella base di calcolo del t.f.r., oltre che degli elementi fissi e continuativi (tipicamente: paga base, contingenza, e.d.r., superminimi) di taluni, pochi, elementi accessori (qualche indennità e, essenzialmente, il lavoro straordinario o quello notturno). La piana applicazione dell’art. 2120 c.c., secondo gli indirizzi dottrinali prevalenti, dovrebbe risolvere con facilità le vertenze, nel senso che ogni corrispettivo erogato dal datore di lavoro concorre a costituire la base di calcolo del t.f.r.. Ma la quotidiana prassi giudiziale fornisce prova della persistente idea secondo cui le corresponsioni debbano, invece, essere caratterizzate dalla continuità e dalla non occasionalità cronologica, tradendo in siffatto modo lettera e spirito dell’art. 2120 c.c..
La struttura di talune retribuzione offre l’occasione per dimostrare, ulteriormente, l’erroneità e l’infondatezza di questa pretesa.
In ambito autoferrotranviario, per esempio, vuoi per ragioni storiche, vuoi per l’entità e l’importanza della contrattazione collettiva nazionale e aziendale (decisamene inflattiva sotto il profilo delle indennità), vuoi per esigenze organizzative interne a ogni impresa, ci si trova spesso di fronte ad aziende che
suddividono la retribuzione in decine e decine di voci, al punto da contarne anche centocinquanta. Viene da sé, pertanto, che, anche per questioni statistiche, l’errato concetto di continuità temporale dell’emolumento finisce per svuotare (o, meglio, impedire il riempimento di) quell’ideale recipiente, nel quale dovrebbe trovare posto la storia retributiva del lavoratore. Tanto più si frammenta la retribuzione tanto meno si riuscirà a cogliere la ripetitività dell’erogazione e, con essa, la continuatività che la giurisprudenza insiste nel richiedere, al fine di costruire la base di calcolo del t.f.r.. Dalla pluriframmentaria suddivisione della retribuzione, infatti, discende un quadro artefatto della storia stipendiale del lavoratore, il quale finisce per vedersi determinato il compenso finale in misura più esigua di quanto non sia previsto dalla legge.
Un paradosso (anche se diverse realtà in ambito autoferrotranviario molto si avvicinano) consente di comprendere quale sia il corretto approccio da riservare al problema.
Se, per assurdo, oltre alle decine e decine di codici che già contraddistinguono la retribuzione di una società, questa decidesse d’introdurne altri, ad esempio, uno per contraddistinguere il lavoro straordinario prestato il lunedì, un altro per lo straordinario del martedì, un altro ancora per lo straordinario del mercoledì e così via, dalle buste paga dei lavoratori, pur impegnati in attività di lavoro straordinario settimanale praticamente fisso ma non quotidiano, non emergerebbe una situazione di costanza nella prestazione di tale tipo di lavoro e nell’erogazione dell’emolumento ma, al contrario, apparirebbero codici del tutto estemporanei che, in applicazione del metodo fondato sul concetto di continuità, finirebbero per essere esclusi per la loro presunta occasionalità (intesa in senso cronologico). Se, poi, una siffatta realtà fosse apprezzata con riferimento al personale turnante, si vizierebbe, vieppiù, quella storia retributiva, che il legislatore dell’82 ha voluto impiegare quale base di calcolo del t.f.r.. Si ipotizzi, infatti, lo scivolamento del turno di lavoro su base giorno/settimana, nel senso che la prima settimana del mese il turno inizi di lunedì, la seconda il martedì e così via; si ipotizzi, poi, che quel lavoratore, tutti i giorni della settimana, svolga un’ora di lavoro straordinario che, tuttavia, si ritroverà in busta paga, contraddistinto dal corrispondente codice retributivo. Qualora la distribuzione dell’orario settimanale fosse su sei giorni, la ripetizione del medesimo codice su base mensile sarebbe, di fatto impossibile, poiché lo straordinario del lunedì comparirebbe, nella migliore delle ipotesi, solo una volta ogni sei settimane. Sarebbe, poi, sufficiente, una sola assenza per ferie, permesso, malattia, per ritrovare il codice solo con cadenza trimestrale. Se, poi, la frammentazione del codice distintivo del lavoro straordinario prevedesse differenziazioni tra quello diurno e quello notturno, tra quello festivo e quello feriale, tra quello feriale e quello prefestivo, esaminando le buste paga di un intero anno, si finirebbe per avere una storia retributiva priva del carattere di continuatività, con conseguente esclusione dei correlativi emolumenti dalla base di computo del t.f.r.. E questo, nonostante il nostro dipendente abbia prestato servizio tutti i giorni oltre il normale orario di lavoro.
Il lavoro straordinario, richiamato in chiave paradossale per introdurre e specificare il tema, costituisce un vero e proprio paradigma.
Invero e a ben guardare, non esiste possibilità d’escludere il corrispettivo del lavoro straordinario dalla dizione codicistica “tutte le somme … corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale”. Di fronte a un siffatto quadro normativo, non esiste, veramente, ragione di soffermarsi, come spesso accade nel contenzioso giudiziale, a discettare sulla strutturalità aziendale del lavoro straordinario continuativo, sulla media dello straordinario prestato, sui picchi anomali di straordinario, giacché rappresentano aspetti inutili e per nulla coerenti con la lettera e lo spirito della legge. È, per converso, necessario seguire un semplicissimo percorso logico che transita attraverso queste tre domande:
- Il compenso per lavoro straordinario è una somma corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro?
- Concorrono a formare la base di calcolo del t.f.r. tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro?
- Può dirsi occasionale (nel significato causale e non numerico come sopra specificato) l’attività di lavoro prestata secondo le ordinarie mansioni demandate al lavoratore e rientrante nell’oggetto sociale della datrice di lavoro?
Se alle prime due domande si risponde sì, mentre alla terza si risponde no (e non si vede quali altre risposte potrebbero darsi), allora il compenso per lavoro straordinario rientra senza il minimo dubbio nella base di calcolo del t.f.r. qualunque sia la sua frequenza, con l’unica eccezione di quei lavoratori per i quali l’azienda ha sempre e invariabilmente stabilito l’obbligo di non prestare, in alcun frangente, attività di lavoro suppletiva e, ciononostante, si siano verificate occasioni (ecco il vero senso del termine) nelle quali, per fronteggiare esigenze del tutto eccezionali, questi lavoratori abbiano prestato lavoro supplementare.
Si saprebbe indicare quale norma giuridica prefiguri un quadro teorico nel quale il lavoro straordinario debba essere continuativo, prevalendo sul chiaro testo dell’art. 2120 c.c., che, invece, fa rientrare nella base di calcolo tutti gli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo per quelli occasionali? Per quanto ci si dia da fare, nessuno sarà mai in grado di individuare, convincentemente, un ragionamento logico giuridico che consenta di esigere la continuatività dello straordinario.
E non si pensi che il ragionamento sia poi così paradossale. Valga richiamare il regime esistente presso un’azienda come A.T.M. s.p.a., che utilizza, solo per distinguere il lavoro straordinario, oltre dieci voci (contraddistinte dai seguenti codici: 330, 350, 357, 358, 359, 360 366, 376, 377, 379, 398), che si moltiplicano in dipendenza del tipo di rapporto: ordinario, a tempo parziale, c.f.l., a tempo determinato.
Orbene, come specificato sopra, proprio il ricorrere a questa pluralità di codici per indicare l’attività suppletiva rischia di far perdere di vista la comune natura
dell’emolumento, con la conseguenza che, nell’ambito dell’errata metodologia qui criticata, per apprezzare numericamente il lavoro straordinario, non è possibile avere riguardo a ogni singolo codice che contraddistingue la compensazione del lavoro oltre il normale orario, ma occorre considerare il fenomeno sotto un aspetto unitario e constatare la ripetizione numerica, alla luce della somma di tutti i codici indicati, dal momento che, seppur distinto da decine di codici differenti, il lavoro straordinario rimane, in tutto e per tutto, lavoro straordinario, sia durante il c.f.l., sia durante un rapporto ordinario, sia durante le giornate ordinarie, sia durante i mancati riposi, sia durante le festività.
Quanto precede consente di confermare la regola aurea.
Per formare la base di computo del t.f.r., pertanto, non bisogna sommare le voci che compaiono continuativamente nei listini paga dei lavoratori, ma sottrarre dalla retribuzione globale percepita dal lavoratore, il corrispettivo per prestazioni del tutto eccezionali, imprevedibili e scollegate con l’ordinario svolgersi dell’attività aziendale nel senso sopra indicato, secondo una metodologia esattamente contraria a quella abituale.
In altri termini, la strada esattamente opposta a quella da sempre percorsa.
Che l’approccio da seguire sia, appunto, quello di matrice causale e non numerica, lo si rileva da un semplicissimo ragionamento, che rappresenta una vera e propria prova del nove per la tesi che si propugna: l’inclusione nel coacervo della tredicesima e della quattordicesima, il cui inserimento nella base di calcolo del
t.f.r. è un dato ammesso dalla unanime giurisprudenza proprio nel nostro settore.
Ora, è ben vero che, pur essendo erogazioni compiute una sola volta nell’anno, il conferimento dell’importo relativo nella base di conto dovrebbe avvenire per la sua costante ripetizione pluriennale, sottraendo efficacia al ragionamento che qui si propugna; ma è altrettanto vero (e in questa parte dell’argomentare risiede la controprova) che, in un rapporto di durata infra annuale, i ratei delle mensilità suppletive concorrono, per certo, a formare la base di computo del t.f.r., secondo una logica del tutto incompatibile con quella che vorrebbe il concetto di occasionalità legato alla cadenza cronologica piuttosto che al titolo.
La base di calcolo dovrà essere effettuata da tutte, ma proprio tutte, le somme percepite dal dipendente, con l’unica esclusione di quelle erogate per esigenze assolutamente anormali e imprevedibili rispetto all’ordinario andamento del singolo rapporto in esame.
Roberto Mattioni
avvocato del foro di Milano