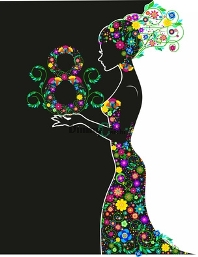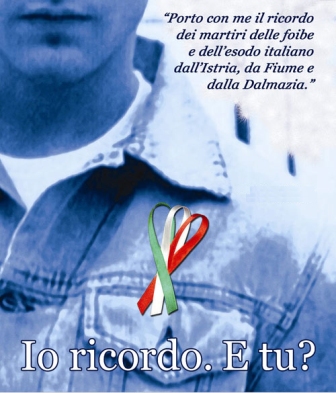1) Il caso
La prassi forense offre spesso spunti di riflessione per approfondimenti teorici, come nell’ipotesi in cui taluno evochi in giudizio il Corpo di Polizia Municipale di un Comune, chiedendone la condanna al pagamento di danni, conseguenti l’agire di alcuni agenti, ritenuti responsabili di illecito civile ex art. 2043 c.c.. Di qui il problema di chiedersi se il rapporto di dipendenza organica, tipico delle suddivisioni amministrative, persista anche di fronte ad articolazioni che, occorre ammettere, presentano peculiarità rispetto agli ordinari livelli costitutivi dell’ente (ufficio tecnico, anagrafico, contabile etc.). Qualche tentazione di ritenere la Polizia Municipale diversa dagli altri elementi costitutivi dell’apparato comunale può forse venire, ma affermare, com’è accaduto, che sia conclusione condivisibile è azzardo non condivisibile.
Il paradigma strutturale è efficacemente articolato nella Legge n. 65 del 7 marzo 1986, di seguito schematizzato:
Art. 1. I Comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale
Art. 2. Il Sindaco o l’assessore da lui delegato, nell’esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull’espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti
Art. 7 comma I. I Comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformità ai principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93, che per inciso attiene alle modalità di sviluppo del rapporto di lavoro in ambito retributivo, sindacale e di controllo
Art. 8. Il Comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico- operativo degli appartenenti al Corpo.
Poiché la vicenda riguardava un Comune della Lombardia e dal momento che la materia è devoluta (anche) alla disciplina regionale, altro riferimento normativo è costituito dalla Legge Regione Lombardia n. 4 del 14 aprile 2003, la quale, nel fare necessitato rimando alla Legge Quadro sopra ricordata, ribadiva la centralità degli Enti Locali – quanto all’organizzazione e alla responsabilità – rispetto ai Servizi di Polizia Locale, stabilendo all’art. 9 del Paragrafo III:
“Al Sindaco e al Presidente della provincia competono la vigilanza sul servizio e il potere di impartire direttive al comandante o al responsabile del servizio di polizia locale per l’efficace raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Ferme restando l’autonomia organizzativa e operativa del comandante e del responsabile del servizio, gli stessi sono responsabili verso il Sindaco o il Presidente della provincia dell’impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti”.
Quanto ricavato dalle citate norme diviene se possibile ancor più stringente ove si consideri la previsione di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957, secondo cui:
“L’impiegato che, nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalle leggi o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell’art. 23 è personalmente obbligato a risarcirlo. L’azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l’azione diretta nei confronti dell’Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato.”
La medesima disposizione veniva ribadita anche al Paragrafo III, art. 6 della citata
L. R. Lombardia n. 4 del 14.4.2003.
Dunque, pura e semplice autonomia funzionale e organizzativa, giammai giuridica, con il potere del Comandante di disciplinare i servizi e le risorse a disposizione, ma non certo stipulare negozi giuridici o di introdurre giudizi, contrapponendosi, esemplificativamente, con l’Ente Pubblico o con altre strutture amministrative, come la Provincia, la Regionale, lo Stato o singoli cittadini.
Peraltro, facendo ricorso alle regole di base che disciplinano la materia, non è possibile dimenticare l’insegnamento secondo cui, per stabilire se esista una persona giuridica, occorra essere in presenza di un patrimonio, staccato da quello delle persone fisiche che la compongono e che questo patrimonio, in quanto destinato a realizzare uno scopo specifico, sia sottoposto a vicende autonome rispetto a quello dei singoli individui. Questa condizione giuridica è riassunta nel concetto di autonomia patrimoniale (anche solo imperfetta), la cui assenza (come nel caso dei corpi di polizia municipale) impedisce d’individuare un soggetto giuridico autonomo, destinatario di obblighi e doveri distinti da quelli dei singoli partecipanti.
La prova è nei fatti.
S’ipotizzi una condanna del Corpo di Polizia Municipale: chi pagherebbe? A quali risorse finanziarie potrebbe mai fare ricorso il supposto debitore? Quali beni aggredirebbe il creditore? E per converso, si pensi a un’ipotetica (quanto fantasiosa) costituzione giudiziale del Corpo con proposizione di domanda riconvenzionale, con richiesta dei danni conseguenti il nocumento d’immagine per la deduzione di fatti inveritieri: chi potrebbe mai incassare il corrispettivo in denaro? Dove sarebbe accreditato? Chi ne godrebbe i frutti?
A ulteriore conforto di quanto esposto, si ponga mente al fatto, poi, che i singoli agenti che compongono il Corpo hanno un rapporto di lavoro con il Comune, loro datore di lavoro, di talché non sarebbe neppure possibile ipotizzare la soggettività giuridica di un ente, che dovrebbe rispondere dei danni causati dai dipendenti di un altro ente.
La conclusione è, dunque, semplice: il Corpo della Polizia Municipale non ha soggettività giuridica e non può, pertanto, essere evocato in giudizio.
Il caso giudiziario non è approdato a decisione: preso atto dell’eccezione, formulata non dal Corpo (che, conformemente, alla tesi sostenuta non si era costituito in giudizio) ma dal Comune, dal quale la polizia municipale dipende, parte attrice ha rinunciato alla domanda.
Novembre 2015 Roberto Mattioni
avvocato del foro di Milano