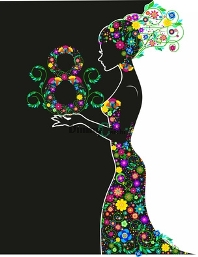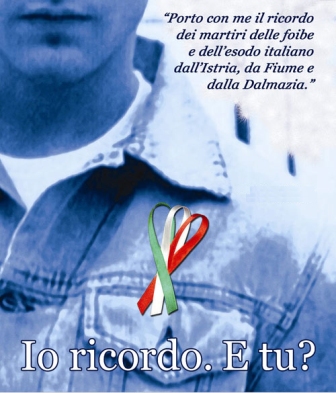1) Caratteristiche del contratto
Le case editrici sono solite selezionare gli scritti da pubblicare (romanzi e saggistica) ricorrendo alla collaborazione di soggetti non strutturalmente inseriti nell’organico d’impresa. Un vario mondo, fatto di casalinghe, impiegati, pensionati, studenti si rende disponibile a leggere i manoscritti che pervengono in redazione e, terminata la lettura, a compilare una scheda di valutazione, all’esito del quale il personale interno delle case editrici assumerà le decisioni in ordine alla pubblicazione degli scritti. Ai lettori, per così dire, estemporanei se ne affiancano alcuni, qualificabili come veri e propri professionisti, nel senso che dedicano strutturalmente il loro tempo allo svolgimento di questa mansione di lettura, valutazione e compilazione delle schede. Il loro è un lavoro di preliminare selezione, nel senso che, in ogni caso, sarà sempre e comunque l’editore e la sua redazione a decidere cosa pubblicare e solo una minima percentuale delle positive valutazioni giungeranno alle stampe.
Lettori estemporanei e lettori professionisti svolgono il loro lavoro in modo differente, essendo i secondi perfettamente in grado di valutare moltissimi lavori e di redigere il proprio personale giudizio in assai minor tempo, specie quelli privi d’ogni valore letterario e didattico: letti gli incipit, a un lettore esperto servono solo verifiche a campione per comprendere d’essere di fronte a pretese velleitarie dell’autore, che era sarà giudicato in modo negativo e sconsigliato per qualsiasi pubblicazione. Lettori di esperienza e capacità, che si dedicano con impegno giornaliero a questa attività, esauriscono l’esame e la schedatura di circa cento manoscritti in circa cinquecento ore, essendo in grado, come detto, di porre in essere tecniche di lettura veloce idonee a consentire i giudizi attesi dagli editori.
Come qualificare il loro rapporto di lavoro?
Nessuna difficoltà e nessun dubbio a considerare di natura autonoma l’estemporanea prestazione di coloro i quali, una volta al mese o, addirittura, con frequenze minori, si rendano disponibili a ricevere, leggere e valutare un manoscritto.
Problemi maggiori, invece, nel caso in cui taluno abbia fatto di quest’attività un lavoro, ricavando per intero o una quota importante di quanto necessario per vivere e dedicandovi le proprie giornate. Si pensi a un laureato in materie letterarie che, per scelta di vita, decida di destinare il proprio tempo a quest’attività, legandosi in modo esclusivo con un editore, il quale, con cadenza settimanale consegni elaborati da sottoporre a lettura e valutazione nei termini indicati.
2) Aspetti formali
Tipicamente, il settore registra l’esistenza di una scrittura privata, o firmata da entrambe le parti nella forma di vero e proprio contratto o sottoscritta dalla casa editrice in forma di lettera di incarico, da cui emergono le caratteristiche qui di seguito indicate.
Parti del rapporto negoziale sono, da un lato, una società editoriale, dall’altro, una persona fisica, non iscritta ad albo professionale, non dipendente da altri datori di lavoro, non titolare di partita i.v.a..
Oggetto del rapporto negoziale sono: la lettura di elaborati redatti da terzi, la loro valutazione in vista di una futura pubblicazione, la proposizione di titoli per i predetti testi, l’indicazione di autori e titoli da inserire in catalogo, la redazione di risvolti e quarti di copertina, la revisione di testi in lingua italiana e traduzioni. Queste prestazioni debbono essere eseguite solo ed esclusivamente dalla persona fisica individuata, con espresso divieto di cessione dell’attività a qualunque terzo. Viene, talvolta, indicata l’esistenza di un programma, consistente nell’esigenza di potenziare questa o quella collana.
La durata dei singoli contratti è variabile ma spesso apprezzabile (dodici, ventiquattro, trentasei mesi), vuoi per iniziale indicazione vuoi per proroghe successive.
Il luogo di esecuzione della prestazione è scelto liberamente dalla persona fisica; è escluso che la prestazione possa essere eseguita in aree di pertinenza della società editoriale; in concreto, la prestazione è svolta presso l’abitazione della persona fisica e/o in altro luogo scelto dalla medesima.
Non esiste necessità di particolari mezzi tecnici, macchinari o altri beni materiali per l’esecuzione della prestazione, la quale si risolve nell’uso del puro intelletto del collaboratore, salvo per le attività di traduzione, per le quali occorrono solo computer e vocabolario, forniti direttamente dal lavoratore; al più, può essere utile l’uso del computer per la compilazione delle schede o per l’elaborazione di commenti, una stampante, vocabolari e dizionari nella diretta disponibilità del prestatore d’opera.
Non esiste, in generale, un tempo di esecuzione della prestazione, nel senso che l’editore, salve eccezioni, lascia libero il lettore di svolgere il proprio compito in fasce orarie non eterodeterminate, potendo l’esaminatore eseguire la prestazione di giorno o di notte, quotidianamente o settimanalmente, secondo la cadenza cronologica preferita.
Esiste una necessità di specifica coordinazione tra le esigenze della Casa Editrice e le prestazioni della persona fisica che, talvolta, sono segnalate in contratto; si
rinviene spesso negli accordi la necessità di coordinazione, segnalata quale bisogno di pianificare, con periodicità settimanale, l’attività del collaboratore.
Il corrispettivo può essere pattuito in misura fissa, indipendentemente dall’attività prestata oppure in base al numero di schede elaborate, con erogazione mensilizzata, al lordo di ogni ritenuta.
È, tipicamente, prevista un’esclusiva a favore del committente, con espresso divieto della persona fisica di assumere incarichi a favore di soggetti concorrenti. Sono, inoltre, previsti obblighi di segretezza, di riservatezza nonché divieti di sfruttare a proprio vantaggio qualsiasi utilità derivante dal contratto.
Vagliando la questione con riferimento all’ultimo decennio, la prassi quotidiana consegna agli interpreti due tipi di negozi giuridici: il primo di natura autonoma, con indicazione esplicita dell’art. 2222 c.c., il secondo di natura parasubordinata ex art. 61 e seguenti del d.lgs. 276/2003, con espressa esclusione del vincolo della subordinazione.
Superfluo affermare che questa relazione possa essere, legittimamente, inquadrata nel rapporto di lavoro di natura subordinata, che costituisce il “tipo” di riferimento nel nostro sistema; inutile, pertanto, soffermarsi su questa circostanza che, peraltro, sembra non avere alcun riscontro nella prassi di settore.
Questione di maggior rilievo attiene, invece, alla possibilità se, a fronte di quanto precede, le case editrici possano inquadrare in forma diversa questa attività, evitando i rischi connessi ad azioni giudiziali da parte dei lettori, rivendicative della natura subordinata del rapporto, con gli oneri contrattuali e legali previsti per questo tipo di contratto.
3) Collaborazioni a progetto
È il contratto, tipicamente, impiegato dalle maggiori case editrici.
L’evoluzione normativa consente oggi di evidenziare tre distinte fattispecie: la prima, antecedente l’anno 2003, costituita dalle cosiddette collaborazioni coordinate e continuative previste dall’art. 403 n. 3 c.p.c. (co.co.co., oggi non più attuali); la seconda introdotta con il d.lgs. 276/2003, sostitutiva della precedente, costituita dalle cosiddette collaborazioni a progetto (co.co.pro., che continueranno a esistere); la terza introdotta con la legge n. 83/2012, il d.l. n. 92/2012 e la legge
n. 134/2012 (riforma Fornero), che ha aggiunto alle co.co.pro. l’ulteriore figura delle “Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo”.
In considerazione della natura della trattazione e dei sui fini, ci si limiterà ad affermare che, per il periodo antecedente l’anno 2003, purché non fossero presenti evidenti segni di una qualche sovra ordinazione gerarchica nei riguardi del lavoratore, sarebbe legittimo sostenere la validità delle collaborazioni coordinate e
continuative (co.co.co.) per lo svolgimento dell’attività di correttore e/o revisore di bozze. E’, però, abbastanza certo che collaborazioni assai prolungate, contraddistinte sì da prestazioni presso il domicilio del lavoratore, pur tuttavia, consistite nella sostanziale messa a disposizione del lavoratore delle proprie energie e capacità professionali, retribuite in modo fisso e predeterminato, con assenza di rischio economico in capo al prestatore d’opera, corrono concreti rischi d’essere qualificate come rapporti di lavoro subordinato.
Con l’introduzione del d.lgs. 276/2003, alle collaborazioni coordinate e continuative si sostituirono le collaborazioni coordinate a progetto, le cui caratteristiche essenziali erano quelle contraddistinte dall’art. 61, il cui testo originale prescriveva che:
“Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa.”
Per quanto interessa i fini della nostra trattazione, queste norma è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che il progetto giammai avrebbe potuto coincidere con l’oggetto sociale della committente, pena la trasformazione della collaborazione in rapporto di lavoro subordinato:
“Sono illegittimi i contratti di lavoro a progetto, stipulati tra una Cooperativa e i soci lavoratori, qualora il progetto consista nell’attività coincidente con l’oggetto sociale della Cooperativa, sicché i progetti consistono nella mera descrizione dell’attività che la Cooperativa svolge senza alcun riferimento al risultato da raggiungere attraverso il progetto né alla realizzazione di un preciso piano di lavoro. In tal caso, mancando il progetto, il rapporto tra le parti deve essere considerato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.” (Trib. Monza, 23/01/2009; analogamente App. Firenze Sez. lavoro, 17/01/2012)
Attento alle evoluzioni giurisprudenziali e alle osservazioni dottrinali, il legislatore del 2012 è intervenuto delineando l’istituto in termini non diversi da quelli emersi dalla prassi giudiziale:
“Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center ‘outbound’ per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione
collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.”
Il legislatore della riforma ha precisato, con norma di interpretazione autentica, che la disposizione concernente le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l’esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda solo le collaborazioni coordinate e continuative, il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario, l’iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea di per sé a determinare l’esclusione dal campo di applicazione del suddetto capo I del titolo VII.
Con particolare riguardo, pertanto, ai contratti di collaborazione a progetto stipulati successivamente l’entrata in vigore dell’art. 61 d.lgs. 276/2003, la
coincidenza, anche solo parziale, dell’oggetto sociale della committente con l’oggetto del contratto a progetto, determinerebbe la più che probabile conversione di quest’ultimo in un contratto di lavoro di natura subordinata; questa conversione sarebbe tanto più certa, quando maggiori siano la continuatività nel tempo, l’assenza di rischio economico in capo al prestatore d’opera, la predeterminazione della retribuzione, la compenetrazione di quanto dedotto in contratto con i fini istituzionali dell’editore committente.
Dopo la legge 92/2012, modificatrice dell’art. 61 del d.lgs. 276/2003, può dirsi ormai assolutamente certo ciò che prima era assai probabile per orientamento giurisprudenziale: se il progetto non è funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e consiste in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente saremo di fronte a un contratto illegittimo, con trasformazione dello stesso in un rapporto di lavoro subordinato.
4) Le “altre prestazioni lavorative” (Riforma Fornero)
Con l’introduzione dell’art. 69 bis nel d.lgs. 273/2003 (Riforma Fornero), il legislatore ha consegnato all’ordinamento giuridico un’ulteriore fattispecie (“Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo”), delineandone il campo di operatività in modo stringente, di fatto, limitando in parte l’operatività tradizionale dell’art. 2222 c.c.:
“Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali.
4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l’integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell’articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l’assolvimento dei relativi obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente.”
Con l’intento di fornire al mondo del lavoro un ulteriore forma contrattuale che si distanziasse dall’archetipo del rapporto subordinato, ma nel contempo e come accennato, delimitando le potenzialità applicative dell’art. 2222 c.c., il legislatore del 2012 ha affidato all’ordinamento una fattispecie senz’altro complessa e articolata, che trova la sua collocazione tra il lavoro autonomo tout court e le collaborazioni a progetto, sì che l’attuale graduazione delle forme tipo risulta essere la seguente:
Rapporto di lavoro subordinato (con le sue molteplici forme: apprendistato, termine, tempo parziale, domicilio etc.)
Collaborazioni a progetto ex art. 61 d.lgs. 276/2003, nella forma ordinaria e in quella “ridotta” (collaborazioni occasioni sino a 30 giorni e sino a €
5.000 l’anno)
Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo ex art. 69 bis d.lgs. 276/2003
Lavoro autonomo
IL PRIMO COMMA DELL’ART. 69 BIS D.LGS. 276/2003
La prima parte della norma stabilisce che, al fine di evitare l’attrazione della fattispecie prevista dall’art. 69 bis nella sfera delle collaborazioni a progetto ex art. 61, occorrerà per il datore di lavoro evitare almeno due delle seguenti circostanze: impegno del lavoratore non superiore a otto mesi in un biennio; erogazione di compensi non superiori all’80% del fatturato complessivo del
prestatore d’opera; non utilizzo da parte del lavoratore di un posto di lavoro presso una qualsiasi sede (o ufficio) della società.
In difetto, opererà una presunzione semplice d’inoperatività della norma e di riconducibilità della fattispecie alla figura prevista dall’art. 61 d.lgs. 276/2003 (collaborazioni a progetto), della quale dovrà possedere tutti i requisiti, primo tra tutti l’esistenza di un progetto non coincidente con l’oggetto sociale della committente, pena l’ulteriore conversione del rapporto in un contratto di natura subordinata. E poiché è assai plausibile che chi dia vita a un contratto ex art. 69 bis d.lgs. 276/2003 lo faccia per evitare l’applicazione della fattispecie prevista dall’art. 61, in particolare per l’impossibilità di individuare un valido progetto, il rapporto contrattuale degraderà per saltum dalla nuova forma di prestazione autonoma all’archetipo del rapporto di lavoro subordinato.
In questa prima fase interpretativa del nuovo istituto occorre richiamare quanto evidenziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, intervenuto nel dicembre 2012 con una circolare avente ad oggetto “indicazioni operative” per il personale ispettivo (Circolare n. 32/2012). Secondo il Ministero, nella determinazione della durata della collaborazione (gli otto mesi previsti dal punto a della norma), non si deve fare riferimento all’anno solare, bensì all’anno calendariale (1 gennaio – 31 dicembre), quindi il periodo da considerare è pari a 241 giorni, anche non continuativi, per due anni consecutivi. Il corrispettivo – inteso come compenso solo per le prestazioni autonome fatturate (anche se non effettivamente incassate) – deve costituire almeno l’80% di quanto ricavato nell’arco di 2 anni solari consecutivi (si tratta di un arco temporale che non coincide necessariamente con l’anno civile).
Qualora un imprenditore decidesse di ricorrere alla fattispecie di cui all’art. 69 bis d.lgs. 273/2003, occorrerà non solo cautelarsi in rapporto alle previsioni stabilite dalla norma predetta, avendo cura di rispettare i parametri cronologici, economici ed organizzativi previsti (8 mesi in un biennio; 80% del fatturato; postazione di lavoro), ma occorrerà tenere in considerazione, da un lato, gli eventuali rischi connessi all’invalidità del contratto di collaborazione a progetto, nel cui ambito, la fattispecie dell’art. 69 bis finirebbe per essere attratta nel caso fosse ritenuta non rispettosa dei limiti legali, dall’altro, le conseguenze tipicamente connesse a ogni rapporto di lavoro autonomo, che abbia un carattere di continuità, con il ricorrente rischio di attrazione nell’archetipo della subordinazione.
Se, infatti, è vero che vige a favore del prestatore d’opera una presunzione semplice, che farebbe retrocedere la fattispecie di cui all’art. 69 bis in quella prevista dall’art. 61 e, da questa, in assenza di progetto nei termini descritti, a quella di cui all’art. 2094 c.c., non andrà mai dimenticato che la relazione giuridica di matrice autonoma (ex art. 2222 c.c) soggiace sempre e comunque alle regole generali; per questa ragione, se accanto o al posto di due dei tre parametri scelti dal legislatore per far operare la presunzione juris tantum, fossero individuati altri indici dell’esistenza di un rapporto di natura subordinata, primo
tra tutti, la soggezione gerarchica con eterodirezione della prestazione del lavoratore, non vi sarebbe dubbio della conversione diretta del rapporto nella forma più tipica, ovverosia, quella subordinata.
Queste conclusioni valgono, a maggior ragione, per coloro i quali sono privi di partita i.v.a., dal momento che l’art. 69 bis sembrerebbe dettato solo i titolari “di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”; i rapporti di chi ne sia sprovvisto, infatti, parrebbero più facilmente e immediatamente riconducibili alle figure previgenti a quella della norma in commento, ovverosia, al contratto a progetto o al rapporto di lavoro subordinato.
Il tempo dirà quale strada sarà seguita dalla giurisprudenza; senza dubbio, qualora si decidesse di avviare un rapporto ex art. 69 bis, occorrerà che il lavoratore disponga di una propria partita i.v.a..
IL SECONDO COMMA DELL’ART. 69 BIS D.LGS. 276/2003
Con l’intento di ritagliare qualche spazio verso l’autonomia della fattispecie, il legislatore ha previsto ipotesi nelle quali la presunzione semplice non opera, indicandole nelle seguenti:
a) qualora la prestazione sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività
b) qualora la prestazione sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 1, comma 3 della legge n. 233/1990.
Come chiarisce il Ministero con la precitata circolare, la formulazione normativa, declinata al plurale (“la presunzione … non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti”), lascia intendere che, ai fini dell’esclusione dal campo applicativo della disposizione, i requisiti indicati devono entrambi realizzarsi in capo al collaboratore.
In attesa della definitiva implementazione della disciplina sulla certificazione delle competenze, contenuta nell’art. 4, commi 64/68 della legge n. 92/2012, la Circolare n. 32/2012 ritiene che il “grado elevato” delle stesse e le “rilevanti esperienze” che conferiscono professionalità al collaboratore possano essere comprovate attraverso:
– il possesso di un titolo rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (sistema dei licei e sistema dell’istruzione e formazione professionale)
– il possesso di un titolo di studio universitario (laurea, dottorato di ricerca, master post laurea)
– il possesso di qualifiche o diplomi conseguiti al termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; apprendistato di alta formazione e ricerca)
– il possesso di una qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in forza di un rapporto di lavoro subordinato e in applicazione del contratto collettivo di riferimento. In tale ultima ipotesi si ritiene tuttavia che solo una qualifica o una specializzazione posseduta da almeno 10 anni possa garantire capacità tecnico-pratiche derivanti da “rilevanti esperienze”
– lo svolgimento dell’attività autonoma in questione, in via esclusiva o prevalente sotto il profilo reddituale, da almeno 10 anni
Per essere considerati utili ai fini dell’esclusione dal campo applicativo dell’art. 69 bis del d.lgs. n. 276/2003, i certificati, i diplomi o i titoli, ovviamente, “devono evidentemente essere pertinenti all’attività svolta dal collaboratore”.
Il possesso delle citate competenze e capacità non è tuttavia sufficiente, da solo, a impedire l’operatività della presunzione; unitamente a esse, infatti, va verificato il conseguimento di un determinato reddito annuo, “non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990”. Il reddito in questione, da intendersi al lordo delle ritenute fiscali, è legato esclusivamente ad attività di lavoro autonomo, con esclusione di ogni altro reddito derivante sia da prestazioni di lavoro subordinato sia da prestazioni di lavoro accessorio (in quest’ultimo caso l’esclusione è peraltro dettata dall’art. 72, comma 3 del d.lgs. n. 276/2003 secondo il quale il compenso “è esente da qualsiasi imposizione fiscale …”).
Detto importo, pari a 1,25 volte il minimale di cui all’art. 1, comma 3 della legge n. 223/1991, è oggi pari a € 18.662,50.
IL TERZO COMMA DELL’ART. 69 BIS D.LGS. 276/2003.
L’art. 69 bis comma 3 esclude dall’applicabilità della presunzione anche le prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione a un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni.
Gli ordini o collegi professionali, i registri, gli albi, i ruoli e gli elenchi professionali qualificati: “sono esclusivamente quelli tenuti o controllati da un’amministrazione pubblica nonché da federazioni sportive, in relazione ai quali l’iscrizione è subordinata al superamento di un esame di Stato o comunque alla necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento dell’attività”.
Viene da sé che quest’esclusione non possa utilmente essere invocata degli editori committenti in relazione al tipo di rapporto oggetto d’analisi.
EFFETTI DELLA PRESUNZIONE
Quanto agli effetti della presunzione, come peraltro già segnalato, il Ministero precisa che la medesima “determina l’integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, ivi compresa la disposizione dell’articolo 69, comma 1”; in altri termini, andrà ricercata l’esistenza di un progetto, pena la conversione in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.
Ancora la Circolare n. 32/2012 chiarisce che, qualora la prestazione sia ricondotta semplicemente a una collaborazione a progetto – ravvisandone quindi i presupposti – occorrerà invece dare applicazione alla restante disciplina di cui al Titolo VII, Capo I del d.lgs. n. 276/2003, ivi comprese le disposizioni in materia di sospensione del rapporto in caso malattia e infortunio e di proroga dello stesso in caso di gravidanza.
PORTATA DELLA NORMA SUL CASO DI SPECIE, SUGLI ALTRI RAPPORTI ATTUALMENTE IN CORSO (PERIODO TRANSITORIO) E SU QUELLI FUTURI
Per quanto concerne i rapporti già interrotti, ma per i quali non sono prescritti i diritti di accertamento circa la natura del rapporto (decennale) e di reclamo di differenze retributive (quinquennale), questa norma non può avere alcuna incidenza, salvo fornire conferme legislative postume degli orientamenti giurisprudenziali previgenti e rendendo, in tal modo, ancor meno dubbio il fondamento dell’eventuale domanda giudiziale che il lavoratore dovesse intraprendere.
Per quanto riguarda, invece, le prestazioni in corso, valgono le medesime considerazioni, nel senso che i predetti rapporti hanno un elevato margine di possibilità d’essere riconosciuti come contratti di lavoro subordinato. V’è, tuttavia, da tenere in considerazione il periodo transitorio di dodici mesi decorrenti dall’entrata in vigore della legge 28 giugno 2012 n. 92, e cioè dal 18 luglio 2012 al 18 luglio 2013, nel corso del quale è possibile adeguare i contratti alle previsioni contenute nell’art. 69 bis d.lgs. 276/2003 (“Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.”).
Questo adeguamento, tuttavia, deve essere posto in relazione con quanto osservato a proposito della prima parte del comma 1 dell’art. 69 bis, il quale parrebbe destinato a operare solo per coloro i quali siano possessori di partita i.v.a.; un’eventuale interpretazione strettamente letterale della norma, infatti, determinerebbe il diritto di regolarizzazione solo per coloro che dispongono di questa minima, embrionale ed esteriore aspetto d’autonoma organizzazione; per chi ne fosse privo, invece, la disciplina sarebbe quella previgente, con automatica riconducibilità, sin da ora, al regime giurisprudenziale formatosi sotto la vigenza
dell’art. 61: o esistenza di un valido progetto o qualificazione subordinata del rapporto.
Per il tempo entro il quale operare l’adeguamento è possibile richiamare la Circolare Inail n. 15 del 20 marzo 2013, secondo la quale il momento a partire dal quale si potrà effettuare una verifica anche da parte dei lavoratori interessati, dipenderà dalla combinazione delle condizioni sopra riportate: ad esempio, se si farà valere la postazione fissa e il fatturato di oltre l’80%, la prima verifica potrà essere fatta non prima del 18 luglio 2014, data di scadenza dei due anni solari previsti dalla legge; se invece, le condizioni sono la durata della collaborazione e la postazione fissa, oppure la durata della collaborazione e il fatturato, la prima verifica non potrà essere effettuata prima del 2015, atteso che il biennio interessato sarà il 2013/2014.
In dipendenza del principio tempus regit actum e per il contenuto del comma 4 ciò che non opererà sarà il regime delle presunzioni, continuando, per converso, a valere i principi generali formatisi sotto la vigenza del precedente art. 61 d.lgs. 276/2003: se le collaborazioni a progetto attualmente in vigore avessero un oggetto coincidente con l’oggetto sociale della committente, non vi sarà la necessità di invocare davanti ai Tribunali il nuovo testo dell’art. 61 per degradare il contratto in rapporto di lavoro autonomo, risultando sufficiente applicare gli orientamenti giurisprudenziali formatisi ante riforma; se le collaborazioni autonome con titolari di partita i.v.a. fossero prive di progetti, occorrerà rispettare le previsioni dell’art. 69 bis, integrando il negozio giuridico con tutti i requisiti sui quali ci si è già soffermati.
PREVIDENZA E FISCO
L’aspetto previdenziale è così riassumibile: aliquota contributiva complessiva pari al 27,72% che si abbassa al 18% per i titolari di pensione o di altra tutela pensionistica così ripartita:
1/3 a carico del collaboratore (da trattenersi sulle buste paga)
2/3 a carico del committente L’Irpef segue il regime ordinario.
5) Contratti a termine
Nel caso in cui sia possibile limitare nel tempo le prestazioni, il ricorso ai contratti a termine eviterebbe l’instaurarsi di vincoli prolungati nel tempo.
La riforma Fornero ha consentito la stipulazione di contratti a termine acausali, ovverosia senza far riferimento allo scopo per il quale il negozio è stato stipulato, di durata massima di un anno, non prorogabili. Per il resto, secondo il d.lgs. 368/2001 occorre sempre indicare le ragioni specifiche per le quali il contratto è stato stipulato, “anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro”. Quest’ultima dizione, che pare assai libera, è però oggetto dell’attenzione degli
operatori e, sino a quando la giurisprudenza non si sarà definitivamente assestata, è sempre meglio utilizzare la massima prudenza, indicando dettagliatamente e con puntualità le ragioni per le quali il datore di lavoro intenda utilizzare questa forma di contratto.
I contratti a termine potranno essere stipulati per un periodo massimo, comprensivo di una proroga, pari a trentasei mesi.
I contratti a tempo determinato scontano, tuttavia, un sovraccosto a carico del datore di lavoro pari all’1,4% rispetto al carico previdenziale e fiscale seguente:
9,19% contributi carico lavoratore
32% contributi carico ditta
23% Irpef
6) Lavoro intermittente
Con riguardo al tipo di rapporto in esame, sembra che la possibilità di ricorrente a questa forma contrattuale sia assolutamente residuale. Vi si può ricorrere per prestazioni di lavoro di carattere discontinuo o intermittente, con lavoratori ultra cinquantacinquenni o infra venticinquenni. Sono previste due forme:
Lavoro a chiamata con obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità se il lavoratore è vincolato alla chiamata del datore di lavoro
Lavoro a chiamata senza obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità se il lavoratore non è vincolato alla chiamata del datore di lavoro.
Al contratto di lavoro intermittente si applica, per quanto compatibile, la disciplina prevista per il rapporto di lavoro subordinato, limitatamente ai periodi nei quali il lavoratore si trova a svolgere effettivamente la prestazione di lavoro che è oggetto del contratto.
Ai fini degli adempimenti previdenziali trovano applicazione le ordinarie previsioni dettate per la generalità dei lavoratori del settore di attività nel quale il lavoratore intermittente viene impiegato. Qualora la durata dell’attività svolta sia stata inferiore a quella contrattualmente prevista per la generalità dei lavoratori della stessa qualifica dipendenti dall’azienda, troverà applicazione il criterio in base al quale il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente, da individuarsi, sulla base delle ordinarie previsioni vigenti per i lavoratori ad orario pieno, deve essere riproporzionato in relazione alla durata della prestazione lavorativa effettivamente eseguita dal lavoratore.
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003 per tutto il periodo in cui il lavoratore intermittente è in disponibilità, in carenza di una prestazione di lavoro, non è titolare di alcun diritto tra quelli riconosciuti ai lavoratori subordinati e non matura alcun trattamento economico e normativo, salva l’indennità di
disponibilità che gli é dovuta quale corrispettivo della espressa pattuizione contenuta nel contratto di lavoro intermittente. L’indennità ha natura di reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 del TUIR, in quanto somma dovuta in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che sussiste l’obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale con riferimento all’importo di indennità pattuito tra le parti nel contratto individuale, senza il rispetto delle ordinarie disposizioni in materia di minimale giornaliero e/o contrattuale di retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
7) Costituzione di società
L’alternativa alla regolarizzazione dei lavoratori in qualità di lavoratori subordinati è quella di prospettare la costituzione di consessi societari o cooperativistici tra lettori e traduttori, con le quali gli editori potrebbero sottoscrivere contratti specifici che regolamentino le prestazioni, prima eseguite dai singoli lavoratori.
A questo riguardo occorre prestare una qualche attenzione sulla mono committenza, nel senso che troverebbero applicazioni i principi di dipendenza economica previsti nella legge sulla subfornitura (n. 192/1998), nonché quelli derivanti dal concetto di dipendenza economica contrattuale ex art. 2359 c.c. comma 1 n. 3, che potrebbero determinare effetti negativi in capo all’editore, a fronte di difficoltà economiche della società, con espansione della responsabilità alle committenti ex art. 2497 c.c.. Sarebbe, in altri termini, opportuno (non necessario) che queste neo costituite società di lettori/traduttori offrissero i loro servizi a più committenti; qualora ciò non potesse realizzarsi, cionondimeno, questo approccio non rappresenterebbe nulla di illecito, dal momento che le conseguenze connesse alla dipendenza economica, se mai azionate, non riguarderebbero la validità dell’operazione, quanto l’eventuale esistenza di danni derivanti da una illegittima determinazione dell’azione del consesso societario (es. imposizione di prezzi tali da non remunerare correttamente i dipendenti/soci).
L’ipotesi sembra, tuttavia, solo teorica, giacché si scontrerebbe con l’esigenza di salvaguardare l’esclusiva di cui gli editori committenti sono, comprensibilmente, gelosi, anche se è tutt’altro che raro il successo di un libro raggiunto con un editore ma rifiutato da altro.
Roberto Mattioni Avvocato del foro di Milano