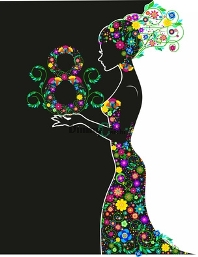1) La fattispecie
Il personale addetto ai servizi sanitari (medici, infermieri, personale tecnico etc.) è, per contratto e per specifiche disposizioni datoriali, tenuto indossare una divisa, generalmente, rappresentata da pantaloni, camici e/o giacche, zoccoli e/o scarpe. I motivi che inducono una tale organizzazione del lavoro sono diversi, dall’esigenza di salvaguardare lo stesso personale e i pazienti da agenti patogeni e contagiosi, all’opportunità di un facile riconoscimento interno a singoli reparti. Normale, pertanto, imbattersi in espresse disposizioni aziendali che impongano al personale sanitario di presentarsi all’inizio del turno loro assegnato, indossando la divisa di lavoro. Altrettanto normale, poi, che le stesse disposizioni aziendali prevedano che il cambio avvenga in area appositamente destinata.
L’ordinaria dinamica del rapporto di lavoro prevede, pertanto, che, una volta varcata la soglia dell’ospedale, i lavoratori raggiungano lo spogliatoio, dove si tolgono gli abiti civili, riponendoli in armadi a loro disposizione, si lavino le mani e gli avambracci, prelevino dall’armadio le divise e si cambiano, per recarsi, poi, al reparto di loro appartenenza. A fine turno, e sempre per espresse disposizioni aziendali, i lavoratori si recano negli spogliatoi, tolgono la divisa, riponendola negli armadietti e lasciano l’ospedale. Le attività di vestizione e di svestizione descritte sono o precedute o seguite dalla timbratura del cartellino in entrata e in uscita.
Le divise sono fornite, in dipendenza degli accordi collettivi, dalla datrice di lavoro, che provvede al loro lavaggio e alla loro stiratura, mettendole poi a disposizione dei propri dipendenti e preoccupandosi di sostituire le divise logore.
In sintesi, le direttive di provenienza datoriale in argomento sono così riassumibili:
– utilizzare la divisa solo ed esclusivamente in ambiente ospedaliero
– indossarla prima di iniziare il turno e previo lavaggio di mani e avambracci
– presentarsi all’inizio dell’orario di lavoro in reparto con la divisa
– terminare l’orario di lavoro con la divisa
– togliere la divisa una volta terminato l’orario di lavoro riponendola per il lavaggio
– timbrare in entrata e in uscita, rispettivamente, o prima o dopo il turno di lavoro e, comunque, senza conteggiare nell’orario di lavoro il tempo destinato alla vestizione e alla svestizione
Viene da sé che, a fronte di quanto precede, si ponga il problema se il tempo dedicato alla vestizione, alla svestizione e alla preparazione debba essere considerato tempo di lavoro (e come tale retribuito), oppure costituisca un onere
accessorio, che gravi sul lavoratore in dipendenza dei principi di collaborazione nell’adempimento della prestazione contrattuale (come tale non soggetto ad alcun obbligo retributivo).
1) Il concetto di “tempo di lavoro” e l’obbligo di remunerare il tempo dedicato al cambio della divisa.
Questione fondamentale da risolvere è quella di stabilire se i lavoratori, nel momento in cui indossano la divisa, adempiono un obbligo contrattuale, dovendo, perciò, essere considerati già in servizio (rectius: in orario di lavoro), oppure, se quest’attività di cambio vestiario debba considerarsi estranea al sinallagma contrattuale, rivestendo i caratteri di una dovuta collaborazione, funzionale al generale obbligo d’adempiere la prestazione ma estranea alla prestazione stessa.
La prima delle due ipotesi si fa preferire sia per le regole generali in materia contrattuale, sia in dipendenza del concetto di orario di lavoro stabilito dall’art. 1 comma 2 del d.vo n. 66/2003, sia per la natura del rapporto delineata dall’art. 2094 c.c..
In primo luogo, a sostegno della tesi favorevole ai lavoratori sovvengono le norme generali dettate dal codice in materia contrattuale, giacché, come ogni rapporto giuridico di matrice patrimoniale, il contratto di lavoro è soggetto al necessario rispetto dell’art. 1325 c.c., il quale prevede, tra gli altri essentialia negotii, la causa, intesa quale ragione giustificatrice del sacrificio patrimoniale del contraente; l’esecuzione di una prestazione, l’assunzione di una condotta, l’adempimento di un obbligo, sia da parte datoriale sia da parte del lavoratore, possono conseguire solo a fronte dell’erogazione di una controprestazione, concretizzandosi in tal modo la natura sinallagmatica del rapporto e il soddisfacimento del requisito legale indicato. Se, dunque, il datore di lavoro pretende dal prestatore d’opera l’assunzione di una condotta, l’adempimento di un obbligo o l’esecuzione di una prestazione, ciò può avvenire solo se sia riconducibile a un vincolo contrattuale e, giusta la previsione dell’art. 1325 c.c., dietro erogazione di un adeguato compenso.
In secondo luogo, conferma la fondatezza di quest’impostazione la natura stessa del rapporto di lavoro che, data la sua matrice subordinata, consente d’affermare la strutturale sovraordinazione del datore di lavoro rispetto al prestatore d’opera, specie per quanto concerne (e per quanto qui interessa) l’orario di lavoro, la prestazione e le modalità esecutive della stessa, Ciò considerato, la disposizione datoriale d’indossare la divisa in ambiente ospedaliero e di presentarsi sul posto di lavoro all’orario unilateralmente stabilito per l’inizio del turno costituiscono estrinsecazione di un tipico potere datoriale, cui corrisponde in capo ai dipendenti una vera e propria soggezione. Il dovere dei lavoratori di presentarsi in reparto all’inizio del turno loro assegnato, indossando un determinato abbigliamento che, tuttavia, non può essere tenuto a casa (e qui indossato) dimostra, senza possibilità
di dubbio, che i prestatori d’opera, nel momento in cui eseguono la disposizione aziendale siano, in tutto e per tutto, a disposizione del datore di lavoro e, per tale ragione, il tempo dedicato al cambio deve essere retribuito.
Il caso in esame non può, dunque, essere ricondotto a quella pur cospicua giurisprudenza che nega il diritto alla retribuzione ai lavoratori obbligati a indossare la divisa, giacché se è corretto non compensare il tempo di vestizione a un autista, a un bigliettaio, a un portiere, a una segretaria, a un impiegato, a un operaio che, pur obbligati a presentarsi sul posto di lavoro con abbigliamento deciso dal datore di lavoro, hanno la facoltà d’indossare gli abiti già presso la propria abitazione e qui farvi ritorno con indosso gli stessi, altrettanto non si può affermare nel nostro caso, ove vestizione e svestizione rientrano nella sfera di influenza e decisione datoriale; se nella prima ipotesi è, di per sé, irrilevante il luogo ove il cambio del vestiario avvenga e lo stesso datore di lavoro, conformandosi alla natura della fattispecie, non interviene stabilendo obblighi di sorta, nel secondo caso, invece, si evidenzia chiara la manifestazione del potere datoriale, che riguarda non solo l’an dell’obbligazione (presentarsi in divisa sul posto di lavoro), ma anche il quomodo (cambiarsi in ospedale, rispettando determinate condizioni). E poiché quest’intervento del datore di lavoro – senz’altro legittimo – produce effetti in ordine alla quantità di tempo messo a disposizione dal lavoratore a favore dell’azienda, non può certo negarsene l’estraneità al sinallagma funzionale del rapporto e, di conseguenza, all’obbligo del debitore di compensarlo.
A controprova della correttezza del ragionamento è sufficiente chiedersi cosa accadrebbe se i lavoratori, pur presentandosi in divisa all’inizio del loro turno di lavoro, si cambiassero presso le loro abitazioni e uscissero dal padiglione con indosso le divise. Nessun dubbio che, di fronte alla specifica disposizione datoriale che il cambio debba essere eseguito in ambiente ospedaliero, esisterebbe un potere sanzionatorio che conferma l’esistenza del vincolo di soggezione/sovraordinazione nel momento in cui i lavoratori indossano gli indumenti da lavoro. E ancora, in termini non dissimili, è sufficiente chiedersi cosa accadrebbe, se i lavoratori iniziassero il proprio turno non con la presenza in reparto, bensì eseguendo la disposizione aziendale d’indossare la divisa tra le mura ospedaliere e, non diversamente, sospendessero la prestazione in reparto per quel tempo necessario a cambiarsi prima di fare ritorno a casa; anche in questi casi, non vi sarebbero dubbi sul potere sanzionatorio datoriale che potrebbe, legittimamente, essere attivato.
Ma non sono solo le regole generali in materia contrattuale, la natura del rapporto e le concrete modalità in cui lo stesso si manifesta a far nascere il diritto dei lavoratori al compenso, ottenendosi anche conferme dalla legislazione in materia di orario di lavoro, secondo la quale (art. 1 comma 2 del d.vo 66/2003):
“Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
a) orario di lavoro: qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”
Così come ha già avuto modo di specificare la giurisprudenza di merito:
“Elemento caratterizzante di tale definizione è l’essere “a disposizione” del datore di lavoro, che trasferisce nell’ambito dell’orario di lavoro la subordinazione, e cioè la soggezione al potere direttivo di controllo del datore di lavoro.” (Trib. Milano, 14/06/2007, in Dir. e Pratica Lav., 2008, 20, 1200).
Del tutto correttamente il Tribunale, facendo propri i principi generali sopra evidenziati, ha individuato nel sinallagma funzionale, costituito dal potere datoriale di direzione e dalla correlativa soggezione del lavoratore, l’elemento distintivo dell’istituto in esame, riconducendo la fattispecie esattamente nell’ambito degli essentialia del contratto di lavoro (supremazia gerarchica e subordinazione gerarchica): in tanto esiste l’obbligo del lavoratore di tenere una determinata condotta, in quanto esiste il diritto del datore di lavoro di pretenderla, con la logica conseguenza che, ogniqualvolta ciò avvenga, il vincolo contrattuale risulti essere in pieno vigore. L’ovvio corollario di questa prefigurazione è che l’attività funzionalmente orientata a realizzare la prestazione tipica e l’oggetto del contratto deve essere retribuita.
In conclusione, il personale sanitario è destinatario di una specifica direttiva aziendale, in forza della quale è fatto obbligo di tenere un determinato comportamento, concretizzandosi in tal modo, da un lato, la supremazia gerarchica e l’eterodirezione della condotta tipiche della supremazia datoriale, dall’altro, il dovere di obbedire, connesso con l’assoggettamento gerarchico; il tempo e il luogo d’esecuzione della direttiva attengono tout court al rapporto di lavoro, dovendo i prestatori d’opera recarsi appena prima e subito dopo l’orario di lavoro stabilito in un’area a ciò deputata dal datore di lavoro, il quale ha predisposto uno spogliatoio e appositi armadi, ove custodire le divise e gli abiti personali, in modo del tutto funzionale rispetto alla propria organizzazione; la direttiva, inoltre, inerisce l’oggetto della prestazione dedotta in contratto e il servizio offerto dalla struttura ospedaliera, realizzando la finalità datoriale di rispettare standard igienici connessi alle prestazioni rese verso gli utenti. Se, per finire, a tutto ciò si aggiungono l’assenza totale di autodeterminazione in capo ai dipendenti e l’esistenza di una vera e propria prohibitio di tenere comportamenti difformi da quelli stabiliti dal datore di lavoro stesso (indossare la divisa in tempi e in luoghi diversi da quelli stabiliti), l’obbligo di retribuire il tempo dedicato alla prestazione alla vestizione e alla svestizione deve essere retribuito.
2) L’orientamento giurisprudenziale contrario (minoritario)
Non è infrequente imbattersi in decisioni di indirizzo negativo rispetto a quanto prospettato nel precedente paragrafo.
Secondo il Tribunale di Milano (sentenza n. 1971, 3 maggio 2010):
“… pare però del tutto evidente che il tempo di vestizione e svestizione … non debba ritenersi competere al lavoratore ove vi sia, come nella specie, un obbligo che derivi dalla normativa igienica e antinfortunistica.
L’esistenza di un obbligo di indossare la divisa, in capo ai lavoratori, deriva dalla sussistenza di disposizioni in materia di igiene, e non può essere ricondotto agli obblighi posti a carico del lavoratore per effetto del contratto di lavoro.
In altre parole, l’obbligo di indossare la divisa deriva dalla particolare natura dell’attività svolta nel reparto, che porta gli infermieri a contatto con pazienti affetti da agenti patogeni contagiosi per cui i dipendenti devono osservare scrupolose e precise prima di iniziare il lavoro e prima di abbandonare l’ospedale (ricorso pag. 1).
E’ quindi evidente il profilo dell’obbligatorietà per il lavoratore di indossare la tuta o altro dispositivo di sicurezza, in quanto ciò risponde ad una esigenza (che si configura come di ordine pubblico) di protezione della salute dei lavoratori …
Non è quindi il datore di lavoro ad imporre ai propri dipendenti di indossare una divisa, e dunque la specifica attività di vestizione e di svestizione si situa fra gli atti di diligenza preparatoria all’effettivo svolgimento della prestazione di lavoro”.
In sostanza, il Tribunale ha affermato che, essendo il tempo dedicato alla vestizione un obbligo legale relativo all’igiene e alla sicurezza, finalizzato a proteggere i lavoratori, deve considerarsi estraneo al contratto di lavoro e al sinallagma e, come tale, non deve essere retribuito. In modo non diverso si è espresso anche Tribunale di Milano, sentenza n. 1664/2011.
La motivazione non solo non convince ma risulta giuridicamente errata sotto diversi profili.
Vi è un primo assunto che non può certo essere condiviso, secondo il quale la vestizione “non può essere ricondotta agli obblighi posti a carico del lavoratore per effetto del contratto di lavoro”. Invero, nel caso sottoposto alla valutazione del Tribunale, i lavoratori indossano la divisa solo ed esclusivamente per effetto del contratto di lavoro, dal momento che, diversamente, non vi sarebbe alcuna ragione di tenere un tale comportamento; non esiste e non può esistere dubbio alcuno che i lavoratori indossino camici, pantaloni e zoccoli, solo perché lavorano presso la convenuta, giacché nessuno di loro, in assenza di contratto di lavoro con l’Azienda Ospedaliera, si sognerebbe mai d’andare in giro vestito da infermiere.
In secondo luogo, la persuasione del Tribunale si fonda su un vero e proprio equivoco, giacché – come del resto è assolutamente evidente prima facie – la divisa degli infermieri non costituisce un presidio per la salute e per l’igiene dei lavoratori, bensì e principalmente per quella dei pazienti e degli altri cittadini. Obbligando gli infermieri a cambiarsi in ambiente ospedaliero e inibendo l’uso della divisa per il tragitto su autobus, metropolitane, strade, esercizi commerciali e altro, il datore di lavoro intende scongiurare che gli operatori sanitari divengano mezzi di trasporto di agenti patogeni, sì che il contrario convincimento del Tribunale non può proprio essere condiviso. Per converso e quantomeno per i ricorrenti, la divisa non assicura alcuna specifica protezione, giacché gli infermieri, anche se indossassero i propri abiti civili o si cambiassero presso la propria abitazione, non si troverebbero in condizioni igieniche e di sicurezza diverse o inferiori rispetto a quelle descritte.
In terzo luogo, pur ammettendo per ipotesi di lavoro e contrariamente a ogni logica, che per i ricorrenti la divisa serva da protezione e l’obbligo non sia di natura contrattuale ma legale, cionondimeno la sentenza risulterebbe in ogni caso e in più parti errata.
Non condivisibile, infatti, l’idea di considerare esistente una disposizione di matrice pubblicistica, che imponga agli infermieri d’indossare ope legis una specifica uniforme in ambito esclusivamente ospedaliero; questa norma, infatti, non esiste e non è mai esistita, tant’è che il Tribunale non è stato in grado d’evidenziarla. Esiste, invece, un’unica fonte dell’obbligo in esame, ovverosia, l’espressa direttiva aziendale, che rappresenta la principale e fondamentale ragione della vestizione e della svestizione in area esclusivamente ospedaliera. A fronte di questa prefigurazione, l’approccio dei lavoratori (e della quasi unanime giurisprudenza) è assai semplice e lineare: laddove l’azienda ordini di tenere una determinata condotta secondo un’adiacenza temporale e funzionale assoluta rispetto al rapporto di lavoro, è evidente che l’attività dei prestatori d’opera, vincolata dalla loro condizione di subordinazione, debba essere retribuita.
Peraltro, quand’anche fosse esistita una disposizione normativa che imponesse agli infermieri d’indossare la divisa per “esigenza (che si configura come di ordine pubblico) di protezione della salute dei lavoratori”, anche in questo caso non potrebbe mai venire meno l’obbligo di remunerazione. Sondando un po’ più approfonditamente il substrato teorico a fondamento della non condivisa tesi del Tribunale (a questo punto già superata da tre autonome argomentazioni), si sarebbe costretti a rimarcarne, viepiù, l’erroneità.
Non esistono difficoltà ad ammettere che il rapporto di lavoro non costituisca un unicum impermeabile, generatore di obbligazioni di matrice meramente pattizia, in quanto in tutti i contratti, non solo in quelli di lavoro, esistono obblighi di derivazione legale, che impongono alle parti di assumere determinate condotte, senza per questo estraniarsi dal sinallagma funzionale e, soprattutto, senza
esonerare la controparte negoziale dall’obbligo di remunerazione. In altre parole, anche se fosse una legge a imporre ai lavoratori determinate condotte, ciò non significherebbe la fine dell’obbligo datoriale di retribuzione e, men che meno, che il dovere legale di tenere una determinata condotta esuli dallo schema causale del negozio.
Il principio giuridico a fondamento della tesi qui espressa è già di per sé evidente, ma se residuasse qualche dubbio è sufficiente porre mente ai plurimi esempi che l’ordinamento ci offre.
L’art. 2104 c.c. è fonte legale ed eteronoma rispetto al contratto individuale di lavoro sottoscritto dal dipendente, ma la diligenza dovuta dal lavoratore nell’esecuzione della prestazione rientra, pacificamente, nello schema logico giuridico del contratto di lavoro subordinato e, come tale, è compensata con la retribuzione mensile; identica sorte per le previsioni contenute nell’art. 2105, nell’art. 2108 e nell’art. 2109 c.c. in materia di contratto di lavoro e per le previsioni di cui agli art. 1175, 1176, 1177, 1178 c.c. per quanto concerne tutti i contratti.
E ancora, con speciale riguardo all’aspetto della sicurezza e dell’igiene.
L’art. 34 comma 12 del t.u. 81/2008, disciplina organica da cui è senz’altro possibile desumere principi generali, stabilisce chiaramente che “la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire … durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”, fornendo così dimostrazione che la provenienza legale proprio degli obblighi relativi alla sicurezza, contrariamente al convincimento del Tribunale, non allontana le condotte del lavoratore dal tipico schema causale del contratto di lavoro ma, addirittura, ne assicura la più che certa attinenza. Ne consegue, dunque, l’impossibilità d’affermare che, proprio laddove esiste un obbligo legale per il prestatore d’opera di assumere condotte destinate a tutelare la propria e l’altrui incolumità, queste siano dovute indipendentemente dal diritto a una retribuzione, giacché, non solo non esiste un principio giuridico in questo senso ma ne esiste uno in direzione esattamente opposta.
L’art. 20 t.u 81/2008, laddove afferma che ogni lavoratore debba prendersi cura della propria salute e sicurezza, “conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”, prevedendo il dovere di “osservare le istruzioni impartite dal datore di lavoro”, fa in tutta evidenza rientrare nello schema causale tipico del contratto di lavoro subordinato tutta l’attività destinata a proteggere la propria e l’altrui salute, senza permettere all’interprete di escludere che il tempo a ciò dedicato non debba essere retribuito ma, al contrario, consentendo di concludere in senso esattamente opposto.
A non diverse conclusioni si perviene riguardando l’art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema protezionistico della salute e dell’igiene sul lavoro, che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure idonee a tutelare l’integrità dei prestatori d’opera, senza certamente affermare che, quando questa attività di protezione è ricompresa nell’orario di lavoro, il tempo ad essa dedicato escluda il diritto alla retribuzione.
Si pensi, infine, all’art. 2110 c.c., norma di matrice pubblicistica dettata sicuramente per proteggere la salute dei lavoratori, che fa emergere in via definitiva l’erroneità della tesi del Tribunale, giacché, addirittura in assenza di prestazione lavorativa (il lavoratore resta a casa per curarsi e quindi per salvaguardare la propria salute), assicura l’erogazione di un emolumento.
Anche contratti diversi da quello di lavoro subordinato, con chiara connessione sovra sistematica, contraddicono il convincimento del Tribunale: il contratto d’appalto, ad esempio, ai sensi dell’art. 26 t.u. 81/2008, deve contenere l’indicazione dei costi che l’appaltatore destinerà per la sicurezza, pacificamente estranei all’ordinario sinallagma contrattuale, ma che del tutto evidentemente rientrano nel corrispettivo pattuito (in tanto l’appaltatore sostiene i costi di sicurezza, in quanto esiste un contratto d’appalto).
Se, poi, si vogliono invocare talune esemplificazioni, ci si convincerà definitivamente che, se esiste un principio generale in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, questo sia di matrice opposta rispetto a quello propugnato dal Tribunale e che cioè l’attività destinata a salvaguardare la salute debba essere compensata.
Quando i lavoratori edili pongono in essere quella lunga serie di operazioni di recinzione di aree e di ponteggi, così da salvaguardare la sicurezza e l’igiene sul lavoro, realizzano attività strumentali all’adempimento della prestazione principale e tipica della loro mansione, ma, non per questo, il tempo ad esse dedicato è escluso dall’orario di lavoro e dalla retribuzione. Quando gli addetti ai cantieri autostradali, prima di riparare un guardrail o un tratto di pavimentazione, pongono in sicurezza i luoghi con l’apposita segnaletica, col chiaro fine di proteggere la propria salute e la propria integrità fisica, non realizzano la loro tipica attività lavorativa, ma non per questo, il datore di lavoro o un giudice si sognerebbero d’escludere il tempo destinato a queste attività preparatorie dall’orario di lavoro e dalla retribuzione.
Gli esempi si potrebbero moltiplicare:
– i sommozzatori o i palombari, che indossano attrezzature necessarie all’esecuzione delle prestazioni e indispensabili per la loro sicurezza, non vedono certo escluso dall’orario di lavoro il tempo dedicato ad assicurare loro la respirazione sott’acqua
– i tecnici dei laboratori a rischio biologico, obbligati a indossare tute e caschi protettivi, maturano la retribuzione durante l’attività di vestizione e svestizione indispensabile a proteggerli dagli agenti patogeni
– ai chirurghi e agli infermieri viene pacificamente riconosciuto come lavoro il tempo impiegato per lo specifico lavaggio e la speciale vestizione prima d’entrare in sala operatoria
– ai lavoratori addetti al trattamento di materiali radioattivi non viene di sicuro sottratto il tempo impiegato per la preparazione e per la decontaminazione
– non diversamente, la moltitudine di lavoratori che, più volte nella stessa giornata, indossano e dismettono abiti e protezioni speciali: i tecnici radiologici, quando indossano vesti protettive, i silvicoltori che si imbragano e che indossano gli altri elementi protettivi prima di salire sulle piante ed effettuare i tagli, gli addetti alla mattazione e alla macellazione che calzano guanti e bardature per il tronco, i pulitori di cisterne che indossano apparecchiature per la respirazione e per la filtrazione dell’aria, gli artificieri con la loro difficile vestizione.
Se poi osservassimo gli interventi dottrinali in materia, ci accorgeremmo che non esistono dubbi sul fatto che il tempo destinato dai lavoratori all’istruzione destinata alla tutela della propria salute sia orario di lavoro (così Margiotta, Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale, pag. 1197; Mammone, Commento al D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 616, in Ambiente & sviluppo n. 8/1995).
In sintesi e conclusivamente, non solo non esiste nel nostro ordinamento giuridico un principio in forza del quale la presenza di fonti legali di diritto, eteronome rispetto al contratto di lavoro, che impongono al prestatore d’opera di tenere determinate condotte finalizzate alla protezione della salute, esclude il diritto alla retribuzione, ma al contrario, un’analisi sistematica della materia consente di affermare l’esistenza di un principio esattamente opposto a quello che costituisce il substrato teorico della sentenza impugnata che dovrà, pertanto, essere riformata.
3) L’orientamento giurisprudenziale maggioritario
Sentenze come quella oggetto d’esame costituiscono, invero, un orientamento minoritario.
Analizzando le decisioni in materia, ci si avvede che esistono principi consolidati, razionali e condivisibili:
“Posto che nell’orario di lavoro ai sensi della nuova disciplina (D.Lgs. n. 66/2003) rientra il tempo necessario per tutte quelle attività preparatorie e propedeutiche all’espletamento di una determinata prestazione lavorativa, rientra nell’orario di lavoro, e come tale va retribuito, il tempo occorrente al lavoratore
per indossare e dimettere la divisa di lavoro in quanto attività funzionali all’inizio della prestazione lavorativa che deve essere espletata utilizzando una specifica divisa imposta dall’azienda.” (App. Milano, 20/10/2005 Cannavò c. Autogrill
s.p.a. Lavoro nella Giur., 2006, 5, 508 Dir. e Pratica Lav., 2008, 20, 1201)
Lo stesso Tribunale di Milano, aveva già posto in evidenza che:
“Si può ritenere che le definizioni di orario di lavoro del D.Lgs. n. 66/2003 siano ricavabili dai principi generali, e come tali idonee a regolare la fattispecie in esame anche per il passato. Il D.Lgs. n. 66/2003, che regola l’oggetto di causa per il periodo successivo alla sua entrata in vigore, definisce l’orario di lavoro come “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. Elemento caratterizzante di tale definizione è l’essere “a disposizione” del datore di lavoro, che trasferisce nell’ambito dell’orario di lavoro la subordinazione, e cioè la soggezione al potere direttivo di controllo del datore di lavoro. Poiché, nel caso di specie, è il datore di lavoro che decide liberamente dove collocare gli spogliatoi nei quali tenere le divise, ed è sempre il datore che pretende che le divise vengano indossate prima di timbrare il cartellino in entrata e dismesse dopo aver timbrato in uscita, il tempo trascorso dai ricorrenti per indossare e dismettere la divisa rientra nell’orario di lavoro e come tale va retribuito. Non così per il tempo necessario alla cura e alla manutenzione delle divise, che non richiede impegno e tempo diversi da quelli che richiederebbe qualsiasi indumento indossato dal dipendente; non vi è pertanto ragione per accollare alla società le spese del tempo di lavaggio e stiratura delle divise stesse.” (Trib. Milano, 14/06/2007 Dir. e Pratica Lav., 2008, 20, 1200).
“Il tempo impiegato dai lavoratori dipendenti per indossare e togliere la divisa obbligatoria, rispettivamente prima e dopo aver timbrato il cartellino, dà diritto alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario (con una maggiorazione del 30%).”(Trib. Milano, 20/11/2007 M. c. Autogrill S.p.A. Lavoro nella Giur., 2008, 8, 854)
“Ove il datore di lavoro, nell’esercizio del proprio potere gerarchico e organizzativo, imponga ai dipendenti di svolgere la prestazione indossando particolari indumenti (nella fattispecie, maglietta, pantaloni o gonna, grembiule, cappellino, pullover e collant per le donne), i tempi di vestizione e svestizione devono essere inclusi nell’orario di lavoro.” (Trib. Milano 13/02/2004, estensore Porcelli, Saro e altri c. Autogrill s.p.a. Riv. Critica Dir. Lav., 2004, 371)
“L’orario di lavoro inizia quando il dipendente – entrando nell’impresa organizzata e diretta dall’imprenditore (art. 2082 e 2094 c.c.) – si assoggetta alle di lui disposizioni. Questa indicazione di massima – in conseguenza della quale ogni attività svolta all’interno dell’impresa s’identifica col tempo di lavoro – non può che essere riconfermata allorquando una certa attività svolta dal dipendente
all’interno dell’unità in cui lavora, è in funzione dell’adempimento di un dovere che il datore di lavoro ha valutato come attinente alla posizione lavorativa. (Nella specie, il tribunale ha riconosciuto la stretta connessione tra attività lavorativa e disposizione aziendale d’indossare una divisa – operazione che poteva essere effettuata solo entrando in azienda – imputando i tempi di vestizione della divisa nell’orario di lavoro prestato.” (Trib. Milano, estensore Mannacio, 10/06/1995 Soc. Sma supermercati c. De Leo e altri Orient. Giur. Lav., 1995, 370)
Sentenza, questa, confermata dalla Cassazione con la pronuncia n. 15734 del 21 ottobre 2003.
“In tema di lavoro subordinato, nella nozione di lavoro effettivo da computare ai fini della retribuzione deve essere compreso anche il tempo strettamente necessario per indossare gli abiti da lavoro.” (Trib. Lodi, 05/04/2002 Bertuzzo c. Sipa s.p.a. Gius, 2003, 1, 91)
Con riferimento alla medesima azienda sanitaria per la quale il Tribunale aveva emesso la sentenza analizzata al paragrafo 2, altro giudice della medesima sezione aveva, per converso, concluso in termini esattamente opposti (sentenza n. 4683/2009, estensore dott. Casella):
“… l’elemento caratterizzante non può che essere la nozione di messa a disposizione delle proprie energie lavorative a favore del datore di lavoro: ciò in quanto trasferisce nel concetto di orario di lavoro l’elemento qualificante del lavoro dipendente, vale a dire la subordinazione, che è data proprio dalla soggezione del lavoratore al potere direttivo di controllo e, conseguentemente, disciplinare del datore di lavoro …
… Nella fattispecie in esame, i ricorrenti chiedono di essere retribuiti per l’attività che essi hanno compiuto per vestirsi e svestirsi ad inizio e fine giornata lavorativa.
In entrambe tali attività entra in gioco il concetto di subordinazione e di attività espletata a disposizione del datore di lavoro che definisce le modalità con le quali quelle attività devono essere svolte.
E’ il datore di lavoro che decide liberamente come e dove venga timbrato il cartellino e se si debba timbrare prima o dopo avere indossato la divisa che peraltro non può – nel caso di specie – che essere indossata in azienda per ragioni igieniche.
Ciò basta per far ritenere fondato il diritto ad essere retribuiti per il tempo impiegato a indossare e dismettere la divisa.
Infatti l’Ospedale richiede che le divise abbiano determinate caratteristiche, siano tutte uguali e che i lavoratori indossino solo quelle fornite dall’azienda e custodite in locali aziendali.
In sostanza, nell’ambito di un obbligo legale, interviene il potere organizzativo del datore di lavoro a determinare le modalità di soddisfazione di quell’obbligo: sicché non si comprende per quale ragione il tempo trascorso dai
lavoratori per soddisfare esigenze organizzative aziendali, sotto il controllo aziendale, per compiere attività strumentali e preparatorie rispetto a quelle lavorative, non debba essere remunerato.”
Anche la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto fondati i principi proposti con il presente atto:
“Il tempo necessario per l’espletamento delle operazioni preliminari (indossare il camice) di carattere strettamente necessario e obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa, deve rientrare nell’orario di lavoro ordinario, trattandosi di attività espletata in ossequio al potere direttivo dell’imprenditore e nel suo esclusivo interesse. Deve pertanto ritenersi illegittimo il comportamento aziendale volto a sanzionare i dipendenti per aver timbrato il cartellino d’ingresso in abiti civili e non dopo aver indossato il camice, come il datore di lavoro pretendeva, al fine di prestare l’attività lavorativa.” (Cass. civ. Sez. lavoro, 14/04/1998, n. 3763)
“Il lavoratore entrando nello stabilimento si sottopone al potere direttivo dell’imprenditore ed è da tale momento che inizia la prestazione lavorativa. Se l’imprenditore ha prescritto l’uso del camice, il tempo per indossarlo rientra nell’orario di lavoro poichè l’obbligo di indossare una divisa imposta dall’imprenditore rappresenta manifestazione di soggezione al potere imprenditoriale.” (Cass. civ. Sez. lavoro, 14/04/1998, n. 3763)
4) Conclusioni
Per quanto si rinvengano alcune decisioni contrarie alle tesi qui sostenute, si crede che il tempo dedicato alla vestizione e alla svestizione nel comparto sanità debba essere considerato “tempo di lavoro” e, come tale, debba essere retribuito. I principi generali sopra esposti hanno, peraltro, capacità e portata espansiva, potendo trovare applicazione in ogni altro settore. L’ampio contenzioso che si sta in questi anni sviluppando proprio in ambito sanitario finirà per approdare in sede di legittimità, e qui la Corte avrà la possibilità d’esercitare il proprio potere nomofilattico, che, si crede, confermerà la fondatezza delle ragioni dei lavoratori.
Roberto Mattioni
avvocato del foro di Milano