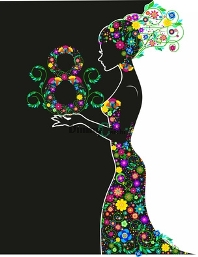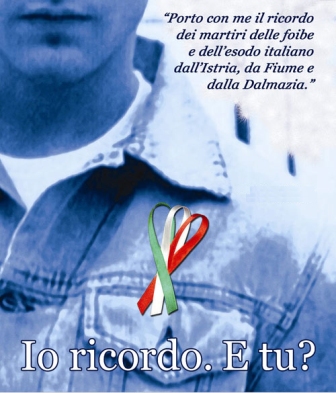1) Il caso
Il contratto collettivo di lavoro della dirigenza medica il 3 novembre 2005, prevede che nelle ore notturne e nei giorni festivi la continuità assistenziale e le urgenze dei servizi ospedalieri siano assicurate o dal Dipartimento di Emergenza, o da Servizi di Guardia e di Pronta Reperibilità. Questa organizzazione consente, sostanzialmente, di fornire ai cittadini l’assistenza di personale medico qualificato tutti i giorni dell’anno e per ventiquattro ore su ventiquattro.
In diverse aziende ospedaliere, mentre nei giorni feriali e negli orari diurni i medici sono tutti impiegati secondo turni predeterminati, la copertura delle ore notturne e dei giorni festivi dei molti reparti in cui sono suddivisi gli ospedali è assicurato dai medici specialisti qui addetti, in alcune aziende ospedaliere il servizio di guardia è garantito solo dai medici addetti a un singolo reparto, in genere, quello di Chirurgia Generale, con esclusione di tutti gli altri chirurghi.
Questo tipo di organizzazione, di fatto, costringe un numero limitato di chirurghi (nei casi analizzati la percentuale varia tra il 20% e il 30% del totale dei chirurghi) ad assicurare il servizio di guardia, consistente nell’obbligo di prestare servizio di notte e durante le festività e si pone in chiaro contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva centralizzata, che si è preoccupata di armonizzare le esigenze dei lavoratori e la necessità d’erogare questo servizio, con la previzione dell’art. 16, il quale così prescrive:
“Servizio di guardia.
1. Nelle ore notturne e nei giorni festivi la continuità assistenziale e le urgenze/emergenze dei servizi ospedalieri e, laddove previsto, di quelli territoriali, sono assicurate … mediante:
a) il dipartimento di emergenza, se istituito, eventualmente integrato, ove necessario da altri servizi di guardia o di pronta disponibilità;
b) la guardia medica di unità operativa o tra unità operative appartenenti ad aree funzionali omogenee e dei servizi speciali di diagnosi e cura;
c) la guardia medica nei servizi territoriali ove previsto.
2. Il servizio di guardia medica è svolto all’interno del normale orario di lavoro …
3. Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa
…”
I contraenti collettivi hanno chiaramente stabilito, che il servizio di assistenza medica per le urgenze e le emergenze presso gli ospedali in orario notturno e nei giorni festivi possa essere effettuato in tre distinti modi:
a) con l’istituzione di un apposito Dipartimento di Emergenza, cui sono addetti medici che in via esclusiva e continuativa svolgono la propria opera in pronto soccorso
b) con l’organizzazione in ciascun Reparto del personale qui addetto (Guardia Medica Divisionale) o tra più Reparti (Guardia Medica Interdivisionale)
c) con l’organizzazione della guardia medica territoriale ove questo sia previsto
In via generale, l’art. 16 comma 3 ha poi sancito che l’obbligo di effettuare le prestazioni di guardia medica spetti a tutti i dirigenti medici, con un’unica eccezione costituita dai primari (Dirigenti di Struttura Complessa).
Presso alcune aziende ospedaliere è invalso l’uso di garantire la continuità assistenziale secondo la previsione di cui alle lettere a) e b) comma 2 dell’art. 16 c.c.n.l., ovverosia, tramite un Pronto Soccorso (Dipartimento di Emergenza) integrato con altri servizi di guardia; questi servizi, presso diversi reparti (es. Medicina Generale, Neurologia, Ginecologia, Pediatria, Cardiologia, Anestesia e Rianimazione), sono assicurati dai medici specialisti qui addetti (Guardia Divisionale), mentre per le unità operative di Chirurgia (es. Generale, Urogologia, Vascolare, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Plastica, Ortopedia) sono solo i chirurghi addetti a Chirurgia Generale a effettuare turni notturni e festivi (Guardia Interdivisionale).
A giudizio di alcune amministrazioni, infatti, il contenuto dell’art. 16 c.c.n.l. è considerato meramente indicativo, privo di valenza precettiva e, sulla scorta di questo convincimento, adottano il sistema testé menzionato.
2) Interpretazione della norma contrattuale
Dottrina e giurisprudenza condividono da tempo comuni principi in ordine alla contrattazione collettiva, dapprima, con l’approdo al concetto di contratto di diritto comune, quindi, con l’individuazione della doppia natura del predetto negozio: normativa, per la disciplina dei rapporti di lavoro, obbligatoria, per la regolamentazione dei rapporti tra associazioni stipulanti. Poiché non v’è dubbio che l’art. 16 c.c.n.l. della dirigenza medica non riguardi le relazioni sindacali, possiamo con sicurezza inquadrare la presente vicenda, avendo come riferimento i principi che concernono la matrice normativa del contratto collettivo di diritto comune e richiamare, così, le regole vigenti in materia di interpretazione del negozio giuridico sanciti dagli articoli 1362 e seguenti c.c..
Prendiamo, pertanto, le mosse dal testo della norma sopra indicata, riportando per comodità l’inciso che interessa:
“3. “Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa”
Che la disposizione sia immediatamente precettiva, configuri un vero e proprio diritto in capo ai lavoratori e non rappresenti l’istituzione di una mera facoltà datoriale lo si desume da una pluralità di elementi.
In primo luogo, dev’essere considerata la sedes materiae dell’art. 16, collocato dai paciscenti collettivi nel Titolo III del contratto, intitolato “Rapporto di lavoro”, con ciò evidenziando come le norme in esso contenute siano finalizzate a disciplinare direttamente la stretta relazione tra datore e prestatore, propria della dinamica del rapporto di lavoro; come insegnano la filosofia e la teoria generale del diritto, tanto la norma giuridica quanto quella contrattuale sono, tipicamente, contraddistinte dalla bilateralità, ovverosia, dalla capacità di far sorgere quella particolare condizione relazionale incentrata sul binomio diritto/obbligo. Se questo è vero, se cioè l’art. 16 c.c.n.l. è norma bilaterale ed è collocata esattamente là dove si stabiliscono le regole che le parti del contratto devono seguire, è difficile sostenere, almeno in linea generale e teorica, l’assenza di precettività delle clausole ivi collocate, ché al contrario la cogenza rappresenta elemento immanente e costitutivo di quelle previsioni destinate a disciplinare qualsivoglia rapporto giuridico. Questa osservazione sistematica della clausola è confermata dall’analisi delle norme rubricate sotto il Titolo III, tutte strutturalmente e finalisticamente deputate a far sorgere tipici vincoli, caratteristici di ogni rapporto di lavoro subordinato: requisiti generali (art. 10), diritti e limiti in ordine all’esclusività (art. 12), orario di lavoro (art. 14 e 15), servizi specifici (art. 16, 17 e 18).
L’argomento assume, si è disposti ad ammetterlo, portata essenzialmente descrittiva della fattispecie, senz’ancor svelare il contenuto della condizione relazionale tipica della norma giuridica e di quella contrattuale, cionondimeno e come si vedrà appresso, costituisce un passaggio preliminare importante e obbligatorio di una compiuta esegesi, specie alla luce dei convincimenti delle amministrazioni ospedaliere.
In secondo luogo, non pare possibile sostenere che l’art. 16 sia destinato a istituire un potere datoriale, generando una correlativa soggezione del prestatore d’opera, considerando la clausola, unicamente, destinata a far nascere non diritti in capo ai dirigenti medici, bensì semplici interessi, addirittura, privi di qualsiasi tutela.
Qualunque contratto collettivo, da sempre, prevede una sistematica che colloca i poteri datoriali di impiego dei lavoratori e la correlativa soggezione dei lavoratori circa i compiti da svolgere, in una specifica e precisa parte, ovverosia, quella dedicata ai livelli e alle mansioni; è esattamente qui che sono posizionate le norme che indicano cosa ogni singolo lavoratore deve fare e, correlativamente, cosa i datori di lavoro possono esigere nell’ambito dello jus variandi orizzontale. L’art. 16 c.c.n.l., invece, non svolge questa funzione, poiché il potere organizzativo datoriale è, nel nostro caso, previsto direttamente dalla legge; sono infatti gli articoli 15-15 quattordecies d.vo 502/1992, nonché l’intero d.vo 165/2011 a
occuparsi di ciò, sì che alla contrattazione di settore sono demandati compiti diversi da quelli già disciplinati dalle norme ordinarie, che prescrivono chiaramente cosa i dirigenti medici debbono fare e, correlativamente, cosa le Aziende Sanitarie possano esigere. La conclusione cui giungono talune amministrazioni risulta, pertanto e in chiave sistematica, contraria all’intero quadro legale e contrattuale del settore sanitario.
Questo approccio interpretativo che esamina, dapprima, la sistematica interna al c.c.n.l., quindi, quella esterna, correlando lo strumento collettivo con il quadro normativo, pur senz’ancora affrontare il testo della norma, permette di per sé di evidenziare l’erroneità della logica che ritiene privo d’efficacia precettiva il disposto del c.c.n.l..
Ma è il testo contrattuale, interpretato secondo gli strumenti che l’esegesi normativa offre da sempre, che consente di svelare l’errore interpretativo. Iniziamo a decifrare il testo della clausola, muovendo dal senso letterale dei lemmi impiegati dai contraenti, i quali così si sono espressi:
“Il servizio di guardia è assicurato da tutti i dirigenti esclusi quelli di struttura complessa”
Il preliminare esame sistematico sopra effettuato, non è stato casuale: se i generali poteri datoriali di direzione e organizzazione sono disciplinati dal d.vo 502/1992 e dal d.vo 165/2001; se il Titolo III del c.c.n.l. della Dirigenza Medica è dedicato agli specifici diritti e obblighi che incombono sulle parti contraenti; se l’art. 16
c.c.n.l. individua, con linguaggio non equivoco, che tutti i dirigenti medici hanno l’obbligo, con l’unica eccezione rappresentata dai primari, è veramente difficile condividere l’interpretazione secondo cui non solo i primari sono esentati dal servizio ma, altresì, lo sarebbero anche tutti gli altri dirigenti medici scelti secondo il gusto personale del datore di lavoro.
Il senso letterale è, univocamente, nella direzione qui suggerita, peraltro, sorretto dall’interpretazione sistematica testé evidenziata.
Se, infatti, i contraenti collettivi avessero voluto veramente prevedere un potere datoriale e una correlativa soggezione del prestatore d’opera, lasciando libere le Aziende Ospedaliere di scegliere a loro piacimento quali dirigenti medici destinare alle guardie, avrebbero necessariamente omesso l’aggettivo “tutti”, originando formule di portata più generica del tipo (per restare attinenti alla fraseologia sotto osservazione): “Il servizio di guardia è assicurato dai dirigenti medici esclusi quelli di struttura complessa” o, meglio ancora: “Tra i servizi che la dirigenza medica deve assicurare rientrano i turni di guardia” et similia. Così, per lo meno, si sarebbero comportati dei redattori approssimativi; quelli buoni, invece, qualora avessero voluto generare la correlazione potere/soggezione lo avrebbero detto chiaramente, decretando che: “La scelta dei dirigenti medici da
impiegare nel servizio di guardia spetta alle A.O.; dal predetto servizio sono esclusi i dirigenti di struttura complessa”.
Nel nostro caso, invece, ci troviamo di fronte a una formulazione difforme, che impiega significativamente l’aggettivo “tutti”, che, come insegnano le regole dell’interpretazione, deve dapprima essere considerato in sé e per sé, quindi, posto in relazione con l’unica eccezione stabilita dalla medesima norma, che riguarda i primari. Se, dunque, i contraenti collettivi, in una clausola lunga una riga e mezza, stabiliscono, nella prima metà, che “tutti i dirigenti” debbono assicurare il servizio di guardia mentre, nella seconda metà, prevedendo l’espressa esclusione da tale compito solo dei primari, significa, da un lato, che solo questi ultimi ne sono esentati, dall’altro, che “tutti” gli altri dirigenti medici sono obbligati a eseguirlo.
I vizi della lettura che ne fanno talune amministrazioni sono, a questo punto, evidenti:
mancata considerazione del lemma “tutti” nel processo interpretativo
mancata valorizzazione della lettura infra sistematica della singola norma, in forza della quale l’art. 16, da una parte, prescrive un obbligo generale per tutti i dirigenti medici di svolgere le guardie, dall’altra, prevede l’esclusione solo dei primari e non di altri
mancata valutazione infra sistematica della norma in relazione al c.c.n.l., in dipendenza della quale le clausole del titolo III sono quelle, tipicamente, deputate a far sorgere i vincoli caratteristici di ogni rapporto di lavoro subordinato
mancata lettura sovra sistematica, che avrebbe consentito di cogliere come le norme descrittive delle mansioni sono collocate in altre parti della contrattazione collettiva o, come nel nostro caso, addirittura, disciplinate dalla legge
La lettura qui suggerita è suffragata anche dalle norme dettate in tema di interpretazione del contratto.
3) Canoni dell’ermeneutica contrattuale
L’art. 1362 c.c. ammonisce di tenere in considerare “la comune intenzione delle parti”; orbene, potrebbe mai ritenersi che Aran e OO.SS. dei lavoratori volessero legittimare così marcate differenze di trattamento tra lavoratori dello stesso livello, consentendo ad libitum dei datori di lavoro la scelta di quali, tra i vari dirigenti medici, dovessero essere “sacrificati” sull’altare delle guardie notturne e festive e quali “privilegiati” con esenzioni compiacenti? La scelta del lavoratore destinato a svolgere queste mansioni, infatti, non equivale ad assegnare uno tra molteplici e vari compiti di pari onerosità e impegno, bensì a gravarlo in misura nettamente superiore alla media, tanto che i contraenti collettivi, consapevoli di ciò, hanno originato la norma in esame. In questa prospettiva, non è forse più
conforme alla logica che informa la contrattazione collettiva, ritenere che si sia voluto generare una norma che consenta trattamenti identici, piuttosto che disuguaglianze marcate e irragionevoli, tali, in ogni caso, da aggravare in modo così pesante la prestazione di alcuni lavoratori a vantaggio di altri, facendole dipendere esclusivamente dalla discrezione datoriale?
Il monito di interpretare le clausole in chiave sistematica deriva dall’art. 1363 c.c., di cui s’è già ampiamente parlato, da un lato, destruttura in modo radicale la convinzione delle amministrazioni.
Nel caso in esame entra in gioco anche l’art. 1365 c.c., che impone alle parti di interpretare il contratto secondo buona fede; ebbene, può forse dirsi rispettato questo principio cardine dell’ordinamento giuridico e dei rapporti tra consociati, allorché ci si trovi di fronte a una clausola che, nell’interpretazione delle amministrazioni, privilegi alcuni lavoratori e ne sacrifica altri, senz’alcuna fondata ragione? Assolutamente no.
E ancora, se è vero che l’art. 1367 c.c. si occupa del principio di conservazione delle clausole contrattuali, di modo che le stesse devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno, non è meno vero che il medesimo principio valga per l’interpretazione della singola clausola contrattuale, come consente di affermare in chiave sistematica l’art. 12 delle preleggi. Da ciò deriva che se i contraenti hanno inteso far ricorso all’aggettivo “tutti”, nel corso del processo interpretativo occorrerà dar conto di ogni lemma e non, come fanno talune amministrazioni, sostanzialmente, intendere la norma come se l’aggettivazione non esistesse.
Anche dall’art. 1368 comma 2 c.c. si possono desumere argomenti favorevoli alla tesi che qui si sostiene, giacché se una delle parti è un imprenditore (cui oggi debbono essere equiparate le Aziende Ospedaliere), le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la medesima impresa, ovverosia, in base a quello che fanno gli altri; e poiché stragrande maggioranza degli ospedali il regime è esattamente quello che qui si sostiene, la tesi dell’assenza d precettività dovrà essere scartata.
Per finire, anche l’art. 1371 c.c. conferma il fondamento dell’interpretazione suggerita dai medici: se, infatti, dovesse residuare qualche incertezza, occorre avere riguardo all’equo contemperamento degli interessi delle parti, che non può dirsi rispettato se le aziende ospedaliere potessero imporre solo a taluni le assai gravose prestazioni esentando a suo piacimento altri.
Conclusivamente, si ritiene che l’art. 16 c.c.n.l. dirigenza medica escluda l’esistenza di un potere datoriale di organizzare il servizio di guardia in modo tale da escludere, in senso assoluto, alcuni dirigenti medici per far gravare i correlativi compiti solo su taluni, preventivamente individuati. Tutti i dirigenti medici
dovranno essere impiegati nel sevizio con l’unica esclusione, rappresentata dai primari.
Roberto Mattioni
avvocato del foro di Milano